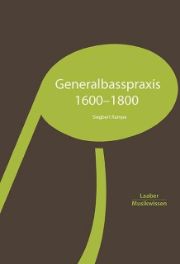Il basso continuo dal 1600 al 1800
Siegbert Rampe divide il periodo in questione in tre sezioni e utilizza esempi per rispondere a molte domande pratiche nel suo libro di testo.

Musicisti, teorici e studenti, in particolare i leader di ensemble, hanno dovuto attendere a lungo per avere una presentazione completa e storicamente fondata delle loro spinose questioni pratiche. Siegbert Rampe ha intrapreso questo compito con una conoscenza dettagliata delle fonti e della letteratura secondaria, non senza fare riferimento alla migliore per i tastieristi. Libro di testo basato su fonti contemporanee per il XVIII secolo di Jesper Bøje Christensen (Kassel ecc. 1992, 62012). Rampe divide il suo libro in tre periodi, 1600-1650, 1650-1750 e 1750-1800, che differiscono fondamentalmente l'uno dall'altro, anche se i confini sono ovviamente fluidi. Tre punti sono tipici del primo periodo: 1) predominano i bassi figurati senza o con una figurazione rudimentale. 2) Il numero di voci poteva variare notevolmente all'interno dello stesso movimento, senza la norma successiva delle quattro voci, per cui queste voci dovevano essere distribuite uniformemente tra entrambe le mani e si privilegiava l'esecuzione a dita piene sul clavicembalo. 3) Lo strumentario era ancora molto vario, comprendendo strumenti a pizzico e strumenti a corda bassa (in posizione di 8 e 16 piedi) di tutti i tipi, trombone, organi di legno e regale. Rampe ha ripetutamente etichettato la distribuzione su entrambe le mani con il termine fuorviante di "movimento ampio". Ricchi esempi musicali di realizzazioni dei primi modelli in notazione modernizzata aiutano l'utente a trarre le giuste conclusioni. Nel caso degli organi italiani, va sottolineato che la maggior parte di essi non aveva pedali o aveva solo pochi pedali fissi e che il limite inferiore dei manuali tra strumenti piccoli e grandi non era standardizzato e poteva essere f, c, fa, do, F1, do1 o (raramente) anche inferiore.
Nella seconda parte, Rampe elimina le opinioni consolidate sulla fusione: Il termine abituale Sonata a violino e violone o cimbalo (Corelli op. 5), basso continuo per strumento ad arco (viola da gamba/violoncello) o a tastiera (p. 79) è da intendersi in senso letterale (che include e non esclude), vale anche fuori dall'Italia e nel XVIII secolo, dove è possibile l'esecuzione accordale del basso ad arco, ad esempio nei recitativi (esempio musicale p. 167). Una marcatura più ricca del basso, a seconda delle dimensioni dell'ensemble, rimane una possibilità. Era consuetudine che la musica da chiesa fosse accompagnata dal grande organo, ma non da un positivo come avviene oggi. La proporzione del pedale dell'organo è oggetto di controversia tra gli esperti, con Rampe a favore di un pedale abbondante e senza menzionare la fermata "Musiziergedackt" in passo da concerto (2 o 3 semitoni sotto il passo del coro) presente su molti grandi organi. - Nei recitativi secchi, l'accorciamento delle lunghe note basse in accordi brevi (compresi i bassi) era la pratica dominante, anche in Johann Sebastian Bach. Questa questione controversa nella letteratura secondaria è descritta e risolta in dettaglio da Rampe, anche se egli discute il recitativo accompagnato solo a pagina 193, probabilmente perché non è controverso. - Molti esempi musicali di "continuo di maniera" forniscono ai praticanti numerosi suggerimenti.
Nella terza parte, il numero crescente di libri di testo è spiegato dal numero crescente di appassionati di musica benestanti. Il loro significato per l'epoca barocca non viene affrontato. Ad esempio, la scuola di basso continuo di Carl Philipp Emanuel Bach del 1762 è illuminante anche per il periodo precedente al 1750, poiché le cantate del padre non solo divennero la linea guida sfruttata per le proprie cantate e passioni, ma ne fece anche il repertorio standard quando divenne direttore musicale delle cinque chiese principali di Amburgo nel 1768. - Rampe ha criticato la scarsa qualità dell'arrangiamento di Kirnberger della sonata in trio nella Sacrificio musicale non riconosciuti o non nominati (p. 188). Si attiene inoltre (p. 197) alla datazione probabilmente errata del Triplo concerto in la minore di Bach. L'ho spiegato in dettaglio e per una buona ragione nel mio libro su Bach. Nel complesso, comunque, il suo lavoro sulle molte questioni individuali di un argomento di grande importanza pratica rimane positivo e vale la pena di leggerlo.
Siegbert Rampe: Generalbasspraxis 1600-1800, (= Grundlagen der Musik 5), 262 p., € 29,80, Laaber-Verlag, Laaber 2015, ISBN 978-3-89007-829-8