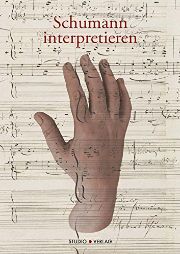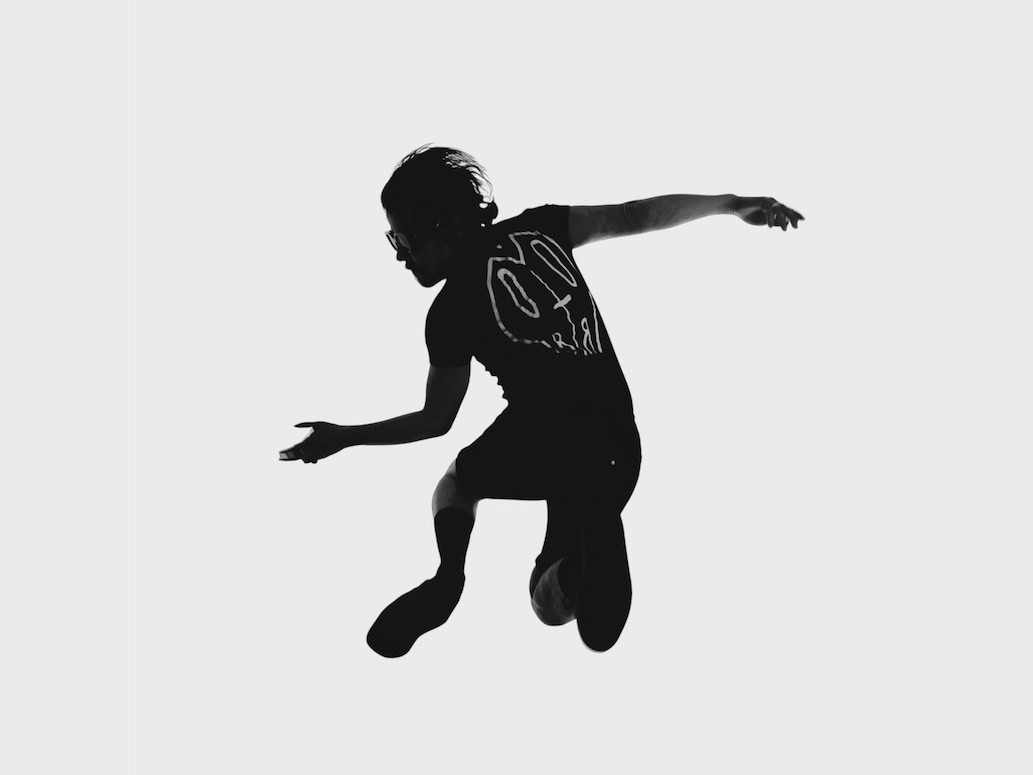Approcci a Schumann
Sono stati raccolti e pubblicati i risultati di un simposio tenutosi alla Basel Music Academy nel dicembre 2010 e alcuni contributi aggiuntivi.

In linea con la tradizione di ricerca di un'accademia musicale, la musicologia dialoga proficuamente con la pratica musicale. Storici ed esecutori dicono la loro e discutono tra loro. Il libro, di 570 pagine, si caratterizza per la sua diversità a vari livelli. Naturalmente, solo alcuni dei ventuno articoli possono essere citati.
Il primo livello da menzionare è l'internazionalità. Oltre a Basilea e al resto della Svizzera, sono rappresentati la Germania, l'Austria, il Canada e gli Stati Uniti come Paesi di origine dei collaboratori. Il libro è in gran parte in tedesco, con l'eccezione di un articolo in francese (Georges Starobinski sui primi cantanti delle canzoni di Schumann) e uno in inglese (un'analisi dell'edizione di Alfred Cortot delle canzoni di Schumann). Kreisleriana di Roe-Min Kok). Tuttavia, sarebbe stato auspicabile un breve riassunto in tedesco, proprio perché la lingua straniera è un'eccezione.
L'incontro tra musicisti e storici si riflette nella diversa forma dei contributi, accanto al tradizionale articolo accademico. Thomas Gartmann intervista Mario Venzago sulle sue esperienze nella direzione delle sinfonie di Schumann. Due dibattiti registrati si concentrano sulle opere tarde di Schumann (Dagmar Hoffmann-Axthelm, Andreas Staier, Michael Struck) e sui problemi di pubblicazione delle opere di Schumann (Bernhard R. Allep, Joachim Draheim, Kazuko Ozawa, Matthias Wendt, Anselm Hartinger). Anche un seminario di interpretazione sulla terza sonata per violino è stato redatto (Hansheinz Schneeberger, Rainer Schmidt - con numerosi commenti da parte di altri presenti all'epoca).
Il libro è monograficamente dedicato a Schumann. Tuttavia, due contributi fanno confronti con altri compositori che non sembrano ovvi a prima vista. John P. MacKeown mette a confronto il lavoro di Schumann Notte di luna (dal Cerchio di canzoni) con Luna ubriaca da Schönberg Pierrot Lunaire. Thomas Kabisch accosta i concerti per pianoforte di Schumann e Liszt nel contesto di una teoria generale della composizione di concerti nel XIX secolo.
Infine, va menzionata la varietà del materiale di partenza che funge da base per le osservazioni. Martin Kirnbauer esamina i numerosi dispositivi meccanici utilizzati come ausili per la pratica, che erano ampiamente accettati e utilizzati all'epoca di Schumann e anche da suo suocero Friedrich Wieck, e che furono la sua personale rovina (in modi non del tutto chiari). Roe-Min Kok è in grado di trarre preziose indicazioni sull'interpretazione di Schumann dall'edizione "acritica" di Cortot. Thomas Synofzik analizza le registrazioni di Carl Reinecke sui rulli per pianoforte Welte (Perché? dal Pezzi di fantasia, 1905) e Hupfeld (n. 6 da Kreisleriana, 1907).
In considerazione del tema unitario dell'antologia, l'indice consiste in un indice delle opere di Schumann trattate.
Interpretare Schumann, a cura di Jean-Jacques Dünki, con Thomas Gartmann e Anette Müller, 570 p., Fr. 38.80, Studiopunkt Verlag, Sinzig 2014, ISBN 978-3-89564-155-8