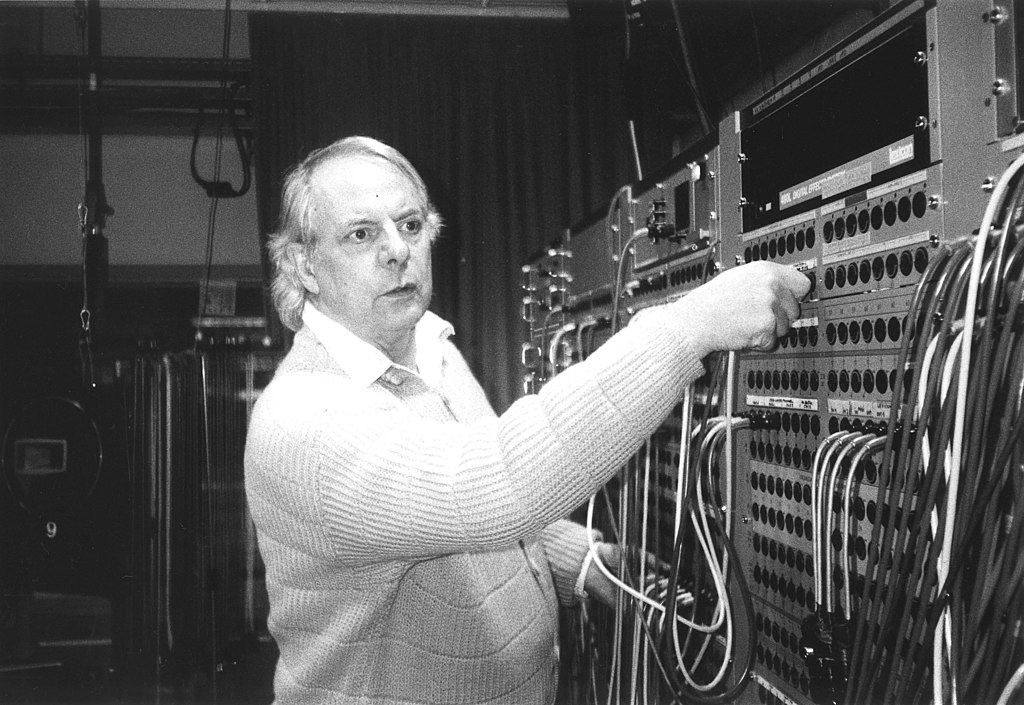Pluralismo invece di demarcazione!
Un'antologia presenta approcci sociologici alla musica.

Un tempo la musicologia si concentrava sulle biografie e sulle analisi delle opere. Solo negli anni Settanta la metodologia si è ampliata. Per dirla senza mezzi termini: gli "orpelli" sono diventati più importanti. Questo includeva le condizioni istituzionali, le considerazioni sull'estetica della ricezione, l'ambiente culturale in cui la musica prospera, così come l'ulteriore sviluppo di quegli approcci che si basavano essenzialmente su Theodor W. Adorno. Sotto l'egida della specializzazione generale, non sorprende che diverse aree di ricerca si siano presto separate: Oggi esistono la psicologia musicale, la musicologia empirica, la musicologia sistematica, l'antropologia musicale e, naturalmente, la sociologia musicale.
Il volume pubblicato da Laaber-Verlag Sociologia della musica non pretende di chiarire la questione del significato di sociologia della musica. Proprio nella prefazione, il curatore Volker Kalisch chiarisce che la sociologia della musica non ha "un'anima".il domanda unica, il interesse guida, il intenzione cognitiva decisiva, circa il metodo che la distingue da altre discipline e argomenti scientifici, circa il strategia di mediazione o attraverso la il sistema chiarificatore di rappresentazione ed etichettatura" (p. 10). Con una rinuncia così rigida al singolare, non c'è altra soluzione che fornire un inventario sotto forma di vari rami di ricerca. 20 autori fanno proprio questo. Affrontano sottili questioni di teoria scientifica come la distinzione tra sociologia della musica e sociologia della musica, la natura dei rituali musicali, gli approfondimenti sui modelli di interazione e sulle strutture di comunicazione. In breve, l'argomento viene definito nel senso dell'etnologo americano Clifford Geertz: attraverso la raffinatezza di un discorso, attraverso la presentazione di aree tematiche selezionate che possono almeno evocare un'immagine di ciò che la sociologia della musica significa, o meglio potrebbe significare.
Due sono le ragioni per cui questo quadro rimane vago alla fine della lettura: Come in ogni scienza umana, le cose non sono così dirette come nelle scienze naturali o nel caso dell'analisi motivico-tematica di una fuga di Bach. Inoltre, la disciplina della sociologia musicale, relativamente giovane, è ancora alla ricerca di un fondamento. È necessario prima stabilire i criteri per ogni studio, e vale la pena di notare che i prestiti metodologici dalla disciplina molto più consolidata della sociologia sono pochi e poco frequenti. Una nota più positiva è rappresentata dagli studi che non sono ancora giunti all'attenzione della musicologia "classica". Sebbene la musica - in tutto il mondo - sia inestricabilmente legata ai rituali, la musicologia "classica" è rimasta senza parole di fronte a questo difficile argomento, mentre Raimund Vogel, Eckhard Roch e Wolfgang Fuhrmann offrono in questa antologia approcci convincenti. L'approccio globale degli autori, con chiari riferimenti all'etnomusicologia e all'antroposofia, è lodevole e giustifica almeno l'esistenza della sociologia musicale, che potrebbe semplicemente considerarsi una disciplina da ampliare. La musicologia nel suo complesso potrebbe trarre grandi benefici se le sue sottodiscipline si completassero a vicenda nel senso del pluralismo metodologico. In ogni caso, un'ulteriore guerra di trincea - alla quale si allude certamente nel volume - sarebbe fatale. Indebolirebbero ulteriormente la già malandata disciplina della musicologia nel suo complesso.
Musiksoziologie, a cura di Volker Kalisch, (=Kompendien Musik Bd. 8), 303 p., 15 ill., € 29,80, Laaber-Verlag 2016, ISBN 978-3-89007-728-4