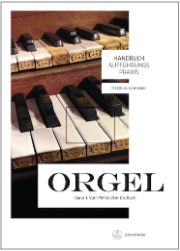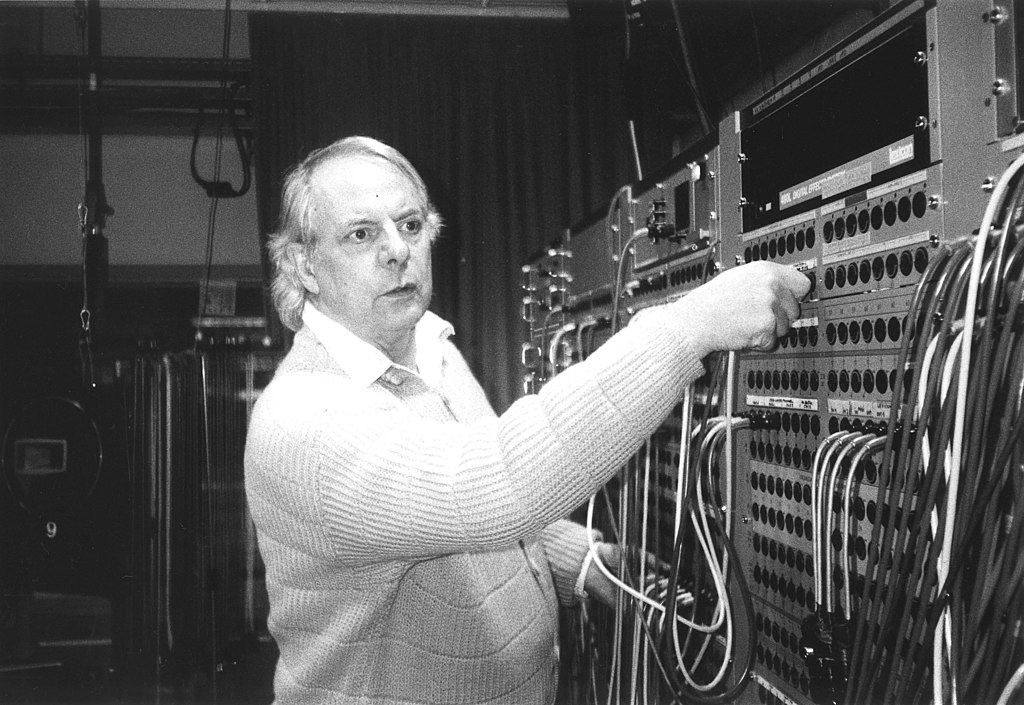Pratica organistica storicamente informata
Matthias Schneider è un esperto riconosciuto di Buxtehude e ha scritto un libro sulla prassi esecutiva dell'organo dal Medioevo a Bach.

Esistono molti libri specializzati per organisti e amanti dell'organo. Ma finora nessuno che parta dal Medioevo e arrivi fino a J. S. Bach. Ora ne ha scritto uno Matthias Schneider, docente all'Università di Greifswald e direttore dei relativi corsi estivi di vacanza. In un secondo volume, il libro proseguirà fino al XX secolo. Dopo un'introduzione sulla notazione, le diteggiature storiche, ecc: Medioevo-Rinascimento, intavolature d'organo della Germania settentrionale, musica italiana, Sweelinck e i suoi allievi, Samuel Scheidt, Dieterich Buxtehude, musica d'organo della Germania meridionale, iberica e francese, e infine Bach.
Si raccomanda a tutti gli utenti del libro di utilizzarlo come opera di riferimento. Leggete il compositore su cui state lavorando. Un vantaggio del metodo di Schneider è che scrive in modo approfondito su alcune opere selezionate. Ciò che si impara qui può essere applicato ad altre opere dello stesso genere.
Dieterich Buxtehude
Buxtehude è una delle specialità di Schneider; è uno dei due redattori della rivista annuale Studi di Buxtehude. Qui discute il compositore in 27 pagine.
Buxtehude non usava ancora la nostra notazione musicale, ma le lettere (la cosiddetta notazione in intavolatura). Non è sopravvissuto un solo autografo. La situazione del tutto insoddisfacente delle fonti ha portato editori di musica validi e non autorizzati a raggiungere risultati molto diversi. Tra quelli non autorizzati, Klaus Beckmann si distingue negativamente per la sua cosiddetta "critica testuale interna". Schneider omette di mettere in guardia da queste edizioni; i problemi possono essere facilmente riconosciuti, ad esempio, confrontandole con l'ultima e migliore edizione di Michael Belotti (anche se queste ultime sono estremamente costose).
La forma non corale nord-tedesca più comune è chiamata toccata o preludio (ma non preludio e fuga, come in seguito accadrà a Bach e ai suoi contemporanei). Consiste in una serie di sezioni libere e fugate alternate. Schneider analizza in modo approfondito un singolo esempio in quasi cinque pagine, la Toccata in re BuxWV 155, per quanto riguarda la segnatura del tempo (la notazione in intavolatura non presenta linee di battuta), la distribuzione tra pedale (raramente etichettato Ped.) e manuale e tra le due mani, la separazione articolatoria dei motivi, la libertà del superlegato e la libertà di inserire ornamenti di vario tipo. La scelta delle registrazioni e dei cambi manuali è una questione di interpretazione. Se e in quale forma le parti organo pleno è appropriato. Le orecchie del pubblico non devono essere affaticate da strumenti dell'epoca del "movimento organistico", che spesso suonano in modo eccessivamente acuto e forte.
All'epoca di Buxtehude, dei suoi predecessori e successori, tali forme erano generalmente improvvisate nelle funzioni religiose e nella musica serale. Le composizioni scritte sono quindi solo dei modelli? L'aspetto più interessante del resoconto di Schneider è l'ampia gamma di libertà. Da ciò si evince che egli non solo è corretto nella sua presentazione musicologica, ma attinge anche alla sua esperienza di direttore di corsi.
Schneider presenta esempi di tre forme di ostinato e parti di ostinato di toccate per la discussione. Le opere corali ricevono un trattamento altrettanto libero. - Schneider descrive l'organo principale di Buxtehude nella chiesa di Santa Maria a Lubecca, costruito nel 1518 e naturalmente accordato su un tono medio, ampliato nel 1561 e nel 1598. Il famoso organaro Friederich Stellwagen lavorò indipendentemente a Lubecca dal 1634. La sua ricostruzione della chiesa di Santa Maria durò fino al 1641. Presumibilmente nel 1684, cioè durante il periodo di Buxtehude, l'organo fu dotato di un'accordatura di compromesso nello stile di Werckmeister III. In questo modo è stato possibile creare chiavi con molte accidentali. Questo aiuta a datare intere composizioni (ad esempio il Preludio in fa diesis minore BuxWV 146) o parti di esse (Preludio in do maggiore BuxWV 137 con triadi in si maggiore).
Per le diteggiature storiche è necessario tenere conto delle seguenti limitazioni: ae voci per mano, sezioni di scala ascendente e discendente, tasti con scarso utilizzo dei tasti superiori. Inoltre, non si applicano a più voci polifoniche per mano. Va inoltre ricordato che tutto l'insegnamento degli strumenti a tastiera avveniva sul clavicordo (ad eccezione dei clavecinisti francesi del XVIII secolo). Sul clavicordo sensibile, ogni dito deve premere sui tasti il più vicino possibile alla parte anteriore. Questo è anche lo scopo delle tastiere in cui i tasti inferiori si estendono solo da 2 a 2,5 cm oltre i tasti superiori, rispetto alle odierne tastiere per pianoforte con 4,5 cm. Infine, nella maggior parte dei Paesi le dita "buone" 1 e 3 sono relativamente enfatizzate, mentre le "cattive" 2 e 4 sono relativamente poco accentuate; in Francia questa situazione è invertita a causa del "jeu inégal".
Johann Sebastian Bach
L'autore gli dedica 49 pagine. Vale la pena di leggere la descrizione dettagliata di Schneider degli organi suonati da Bach durante la sua vita e le istruzioni di registrazione dell'epoca. Ad esempio, tratta l'indicazione "pro organo pleno" con attenzione e differenziazione: Non tutti i preludi e le fughe possono tollerare un suono forte. Schneider avrebbe potuto aggiungere condizioni acustiche fondamentalmente diverse e gli effetti dei climi marittimi e continentali: Mentre nella Germania settentrionale predominavano le grandi chiese gotiche in mattoni, con un riverbero lungo, le chiese della Turingia, paese natale di Bach, avevano molti infissi in legno, quindi un riverbero breve. Ciò consentiva a Bach di comporre rapidi cambiamenti armonici senza risultare incomprensibile per la congregazione. Il clima ebbe gravi conseguenze sulle disposizioni dell'organo: molte canne nella Germania settentrionale, solo poche nella Germania centrale e miscele di canne contenenti terze come sostituto. Il principio di base si applica ancora oggi: suonare lentamente con un lungo riverbero e utilizzare il minor numero possibile di stop e il più silenzioso.
Molti organi all'epoca di Bach non avevano una fila cromatica completa nell'ottava maggiore. Schneider parla della cosiddetta "ottava corta", dell'"ottava spezzata" e del do diesis quasi universalmente mancante in tutte le parti del suo libro. Solo la chiesa del castello di Weimar aveva il Do diesis nei due manuali e nel pedale (contrariamente alla descrizione imprecisa di Hermann J. Busch, corretta da Jean-Claude Zehnder). Bach soggiornò a Weimar per 6 mesi a partire dal gennaio 1703, impiegato a corte come "Laquey". Nel penultimo brano della serie di partite su Oh, cosa devo fare peccatore BWV 770 contiene l'infido Do diesis una volta nella mano sinistra. Ciò consente di datare l'opera a questo periodo. Schneider discute meritatamente in dettaglio quest'opera deliziosamente giovanile.
Molte opere organistiche di Bach sono state scritte durante il periodo di Weimar: la Libretto d'organoi 17 grandi arrangiamenti di corali (leggermente rivisti dopo il 1740 come Corali di Lipsia etichettati), più della metà dei suoi preludi e fughe e gli arrangiamenti di concerti dopo la L'estro armonico op. 3. Ogni genere è trattato in dettaglio con alcuni esempi. Mancano tre preludi: La maggiore BWV 536, Fa minore BWV 534 e Do minore BWV 546, le cui fughe sono state messe in dubbio da David Humphreys e Peter Williams. Tuttavia, sono riuscito a dimostrare che sono stati scritti molto tempo prima e che la fuga in la maggiore deve essere suonata manualmente, con il pedale aggiunto solo poco prima della fine (in: L'annuario dell'organo 2008).
Schneider ha certamente ragione quando scrive nelle 6 sonate da camera per trio BWV 525-530, composte per il figlio maggiore Wilhelm Friedemann, che è sufficiente una battuta per voce, che la mano sinistra può essere diteggiata un'ottava più bassa con quattro piedi per una più comoda suonabilità e, soprattutto, che un sedicesimo piede è superfluo per il pedale. Schneider avrebbe potuto citare le cantate con organo obbligato del ciclo del 1726/27, anch'esse scritte per Wilhelm Friedemann prima di lasciare Lipsia.
Cosa si dovrebbe aggiungere in una seconda edizione di questo manuale fondamentale: casi di temporalizzazione nella "proportio sesquialtera". Ecco solo due esempi impressionanti: Preludio e fuga in la minore BWV 543: le crome del misurato e stridente preludio, carico di molte dissonanze, occupano lo stesso tempo di tre crome della fuga in contralto. Il preludio e la fuga in sol maggiore BWV 541 si comportano al contrario: battute intere nello stesso periodo delle mezze battute della fuga. Questo è l'unico modo in cui il preludio con la marcatura Vivace può sviluppare la necessaria effervescenza senza un tempo esagerato nella fuga impegnativa.
Matthias Schneider: Handbuch Aufführungspraxis Orgel, Volume 1: Dal Medioevo a Bach. 267 p. copertina rigida € 49,95, Bärenreiter, Kassel 2019, ISBN 978-3-7618-2338-5